“Io voglio riattivare quel rapporto tra intellettuali e arte che si è interrotto ai tempi di Moravia, Pasolini o Sciascia”, dichiara infatti lo storico dell’arte ferrarese. Cosa di cui abbiamo gran bisogno dato che il contemporaneo è spesso esiliato in una nicchia scomoda e asettica. “Il mio compito sarà indicare il punto di vista delle 200 persone dotate di miglior pensiero in Italia e all’estero. In Italia soprattutto, esistono stimabili intellettuali, come Arbasino,
 Ceronetti, Eco, Colombo o Scalfari, che si pronunciano o si sono pronunciati su varie discipline, dal cinema al teatro alla letteratura ma non sulle arti visive”. Uomini di grande cultura, ma anche età avanzatissima e tutti con una formazione letteraria (perché ad esempio non scegliere pure musicisti, scienziati o di economisti?), che non è detto che abbiano qualcosa da dire, ma il gioco potrebbe valere la candela se vogliamo togliere l’arte dagli eccessi autoreferenziali degli addetti ai lavori. Insomma, non ci resta che vedere se sarà una mostra tutta chiacchiere e distintivo oppure qualcosa di diverso.
Ceronetti, Eco, Colombo o Scalfari, che si pronunciano o si sono pronunciati su varie discipline, dal cinema al teatro alla letteratura ma non sulle arti visive”. Uomini di grande cultura, ma anche età avanzatissima e tutti con una formazione letteraria (perché ad esempio non scegliere pure musicisti, scienziati o di economisti?), che non è detto che abbiano qualcosa da dire, ma il gioco potrebbe valere la candela se vogliamo togliere l’arte dagli eccessi autoreferenziali degli addetti ai lavori. Insomma, non ci resta che vedere se sarà una mostra tutta chiacchiere e distintivo oppure qualcosa di diverso.Di certo Sgarbi vuole “spossessarsi della dimensione curatoriale”.
Fa ridere però l’idea di affiancare al padiglione lagunare una selezione di mille artisti su base regionale da esporre diffusamente in Italia: evidentemente l’arte, nell’idea di Sgarbi, è come il vino, l’olio e i formaggi e le tradizioni locali. E poi dove si trovano mille artisti bravi?
Ho come l’impressione che un po’ piangeremo e un po’ rideremo…


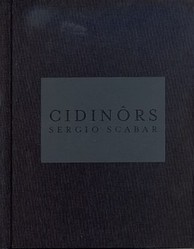 Stavo riordinando i cataloghi degli ultimi mesi e mi sono trovato tra le mani la curatissima pubblicazione che ha corredato la personale di Sergio Scabar presso l’Ospedale dei Battuti di San Vito al Tagliamento (potete leggere
Stavo riordinando i cataloghi degli ultimi mesi e mi sono trovato tra le mani la curatissima pubblicazione che ha corredato la personale di Sergio Scabar presso l’Ospedale dei Battuti di San Vito al Tagliamento (potete leggere  Pregiudizi di ogni tipo sono quelli che molta della critica progressista e à la page del nostro paese ha nei confronti della pittura. La cosa si vede, oltre che nelle mostre in molti negli spazi pubblici, dalla costante assenza del medium nelle gallerie considerate portatrici della ricerca più innovativa, di quelle più ambite e snob.
Pregiudizi di ogni tipo sono quelli che molta della critica progressista e à la page del nostro paese ha nei confronti della pittura. La cosa si vede, oltre che nelle mostre in molti negli spazi pubblici, dalla costante assenza del medium nelle gallerie considerate portatrici della ricerca più innovativa, di quelle più ambite e snob. Sconcertante è la leggerezza con cui i quotidiani italiani trattano di arte contemporanea, usando parole a sproposito, al di fuori di qualsiasi logica di buon senso. Questa volta èRepubblica.it a sorprenderci, nella classica colonnina cazzabubbole della homepage sulla sinistra, il refugium peccatorum dell’utente in cerca di distrazione (spazio in cui tra l’altro mi è capitato di vedere artisti sconosciuti al grande pubblico ma di sicuro interesse come Chris Gilmour). Qui ieri campeggiava un link dal titolo, molto promettente, “il capolavoro lavato via”. Non riesco a capire di cosa si tratta, immagino un’istallazione di John Bock pulita con la candeggina o
Sconcertante è la leggerezza con cui i quotidiani italiani trattano di arte contemporanea, usando parole a sproposito, al di fuori di qualsiasi logica di buon senso. Questa volta èRepubblica.it a sorprenderci, nella classica colonnina cazzabubbole della homepage sulla sinistra, il refugium peccatorum dell’utente in cerca di distrazione (spazio in cui tra l’altro mi è capitato di vedere artisti sconosciuti al grande pubblico ma di sicuro interesse come Chris Gilmour). Qui ieri campeggiava un link dal titolo, molto promettente, “il capolavoro lavato via”. Non riesco a capire di cosa si tratta, immagino un’istallazione di John Bock pulita con la candeggina o  ardia stanno riscoprendo negli ultimi quattro-cinque anni, come ad esempio è capitato con il grande Jiri Kovanda: insomma è à la page, ma si compra abbastanza bene poiché i collezionisti ancora non ci hanno messo troppo gli occhi (che strano destino, la storiografia conta tantissimo, ma in arte è possibile correggersi dato che le opere non necessariamente spariscono).
ardia stanno riscoprendo negli ultimi quattro-cinque anni, come ad esempio è capitato con il grande Jiri Kovanda: insomma è à la page, ma si compra abbastanza bene poiché i collezionisti ancora non ci hanno messo troppo gli occhi (che strano destino, la storiografia conta tantissimo, ma in arte è possibile correggersi dato che le opere non necessariamente spariscono). Com’era prevedibile la mostra di Cattelan a Milano ha creato una serie inenarrabile di polemiche. In maniera particolare, dopo il suo piccolo Hitler sui manifesti, è il suo Dito medio (i titoli reali sono Him e Love) installato di fronte alla Borsa a tenere banco.
Com’era prevedibile la mostra di Cattelan a Milano ha creato una serie inenarrabile di polemiche. In maniera particolare, dopo il suo piccolo Hitler sui manifesti, è il suo Dito medio (i titoli reali sono Him e Love) installato di fronte alla Borsa a tenere banco.