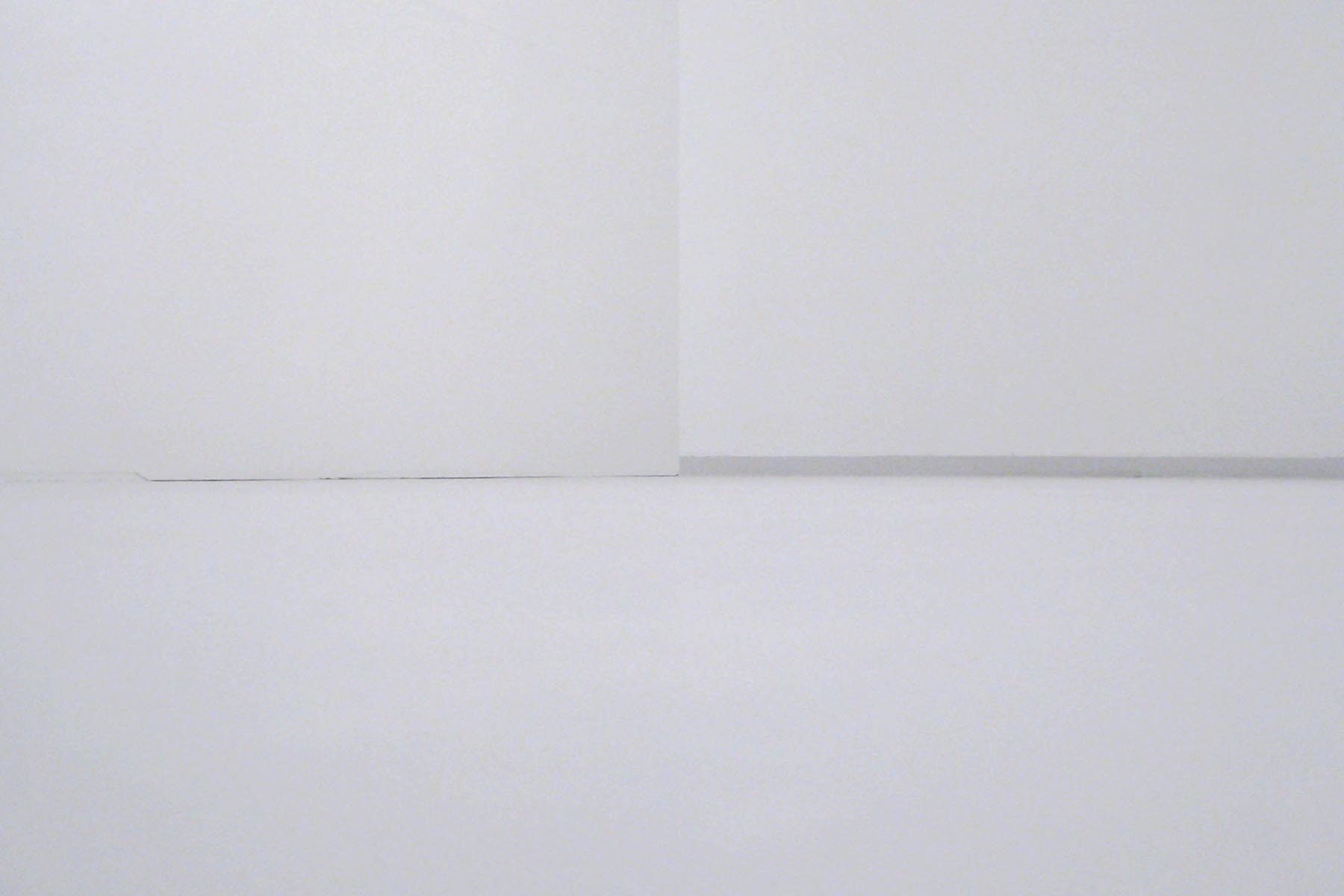Michele Spanghero
Exhibition Rooms
Verona, Artericambi
febbraio ― marzo 2010
L’auspicabile miopia
Daniele Capra
Molto spesso organizzare una mostra è come ospitare molte mostre dentro le mostre, un po’ come delle Matrioska. Ogni mostra può nasconderne un’altra.
Hans-Ulrich Obrist, Connective Possibilities
Quando si mostra il cielo con un dito lo sciocco guarda, e di conseguenza vede, il dito. Questo è quello che ci hanno raccontato sin da bambini, stimolandoci a fare l’esatto opposto. Parimenti anche il metodo scientifico ci indica come sia necessario riconoscere l’oggetto della nostra analisi e quali siano gli aspetti da prendere in considerazione, usando intelligenza e soprattutto strumenti di analisi e misura per accertare. È un aspetto cioè metodologico, dato che – per formulare delle ipotesi, per capire oltre le apparenze – è necessario saper dove guardare.
Capita così anche in occasione di una visita ad una mostra di arte contemporanea, tanto negli spazi pubblici quanto in una galleria: quando entriamo in un luogo in cui sappiamo esserci una mostra ricerchiamo prima di tutto le opere che contiene. Indipendentemente dal fatto che siano autonome, cioè semplicemente collocate nel posto perché trasportate da altrove, o realizzazioni site specific, è il soggetto contenuto nello spazio ad attirare la nostra attenzione (anche nel caso in cui si tratti di un’opera sostanzialmente immateriale come può essere un lavoro di sound art, o nella situazione limite di una performance, dove l’opera è frutto dell’accadimento). La fonte primaria di interesse è cioè nei riguardi di quello che sta dentro, in ciò che avviene nel contenitore.
Benché nell’ultimo decennio si sia registrata una certa propensione, talvolta manifestamente enfatica, in allestimenti volutamente alternativi delle mostre (spaziando da soluzioni molto raffinate a vera e propria sciatteria), il white cube è ancora considerato il modello di contenitore di riferimento: l’ambiente bianco infatti garantisce, come nessun altro, un tipo di esperienza sensoriale assoluta. Scrive Brian O’Doherty in una raccolta di saggi: «la galleria ideale elimina dall’opera tutti gli elementi accidentali che interferiscono con il fatto di essere ‘arte’. L’opera è isolata da qualsiasi aspetto che possa distogliere dalla sua stessa valutazione artistica. Questo conferisce allo spazio una caratteristica che è propria di altri spazi in cui le consuetudini sono preservate grazie alla ripetizione di un sistema chiuso di valori. Un po’ della sacralità di una chiesa, la formalità di una corte di tribunale, l’arcano di un laboratorio sperimentale convivono con un design chic per creare una camera per l’esperienza estetica» [1].
L’analisi che Michele Spanghero sta portando avanti da più anni sui luoghi espositivi nasce invece dalla concomitante volontà di guardare il dito e non il cielo, ma anche di mostrare quanta differenza si registri tra i modelli concettuali e la realtà. L’artista ha compiuto una vera e propria ricognizione degli spazi espositivi dell’Italia e dell’Europa centro orientale (musei, kunsthalle, gallerie e fiere) alla ricerca tanto degli elementi di omologazione quanto quelli di discontinuità dei siti, rivelando aspetti contingenti cui solitamente non si presta attenzione. In questo modo si scopre come l’impiego del white cube ammetta eccezioni e molte differenti declinazioni rispetto al modello assoluto che si crederebbe inderogabile.
L’aspetto fondamentale di questa indagine è il capovolgimento del ruolo funzionale e, inaspettatamente, del potere e del vincolo di soggezione (visivo, culturale, estetico) che alimenta la gerarchia opera/luogo. Mostrando ed esibendo manifestamente non tanto pavimenti e pezzi di muro bensì porzioni e ritagli di recipienti, essi stessi cessano di essere afasici contenitori di vuoto ed iniziano a bisbigliare, a mostrare inaspettatamente crepe, irregolarità e variazioni della gamma dei bianchi cui non siamo soliti prestare attenzione. In questo l’artista compie un gesto di insubordinazione rispetto alla logica standardizzata in cui i ruoli sono assegnati ed il copione non permette cambi di parte, nemmeno all’ultimo minuto. Spanghero non sceglie così dei nuovi soggetti, non implementa cioè la lista di possibili cose da guardare, ma spoglia gli spazi delle opere: le manda letteralmente in soffitta, ignorandole. È infatti il microcosmo che noi siamo abituati a considerare cornice ad essere fotografato. Le opere, quelle che già godono dello status privilegiato di essere pezzi d’arte, e che sono collocate sulle pareti o appoggiate sul pavimento alle spalle dell’artista, non ci sono, latitano, e nemmeno a quel punto vale la pena di tendere l’orecchio per sentire se tacciono in forma definitiva.
La ricognizione di tutti questi spazi – sono qualche centinaio le foto scattate dall’artista goriziano – porta a termine un interessante lavoro processuale di compressione visiva che non lascia spazio ad interpretazioni di natura percettiva, benché non manchino dei risvolti cromatici interessanti che potrebbero inserire le fotografie nell’alveo del minimalismo. Ma, come ricorda Jean Baudrillard ne Il sistema degli oggetti [2], l’attività reiterata del collezionare, di raccogliere oggetti e concetti con un criterio riconoscibile o in grado di formare una relazione di vicinanza logica, ha per conseguenza il controllo ed il dominio dello spazio e del tempo. L’azione dell’artista di documentare porzioni di contenitori che risultano vuoti o svuotati, lo trascina inevitabilmente ai limiti delle possibilità rappresentative dello strumento fotografico, ma lo mette nel contempo nella posizione privilegiata di essere riuscito a documentare e dominare un processo. Risulta in questo modo forte la tensione analitica dell’operazione nell’essere causticamente ripetitiva; inoltre l’attrito concettuale tra la fotografia di una serie di non-soggetti (i white cube di Exhibiton Rooms) e la loro evidente riconoscibilità (in quanto pareti e pavimenti) rende la frizione gelidamente tagliente. La magia però talvolta – come capita in Amarcord quando la nebbia avvolge la città di Rimini – è non vedere distintamente e lontano, ma poter scoprire a tentoni.
[1] B. O’Doherty, Inside the White Cube. The Ideology of the Gallery Space, University of California Press, Berkeley, 1986, p. 14.
[2] J. Baudrillard, Il sistema degli oggetti, Milano, Bompiani, 1972-2004, p. 122.